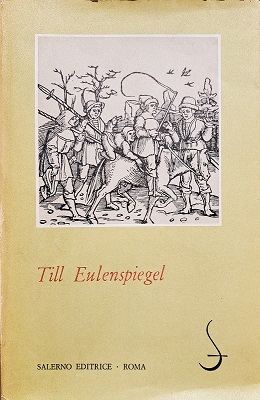
| * HOME * | * LIBRI * |
Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2025 (Floréal - Muguet)
Nulla atterrisce più di uno specchio una coscienza non tranquilla.
(Pirandello, "Sogno (ma forse no)")
Il libro - Il personaggio - Il linguaggio - L'informatica - L'esempio
Il libro
Si tratta di un libro di narrativa, di racconti brevi per la precisione, illustrato, e le illustrazioni sono a mio avviso pregevoli.
Anche se ci fosse stato solo in tedesco l'avrei preso lo stesso solo per le illustrazioni.
Till Eulenspiegel,
è un personaggio leggendario famosissimo in Germania, ma più in generale anche nei paesi di lingua tedesca; lo è decisamente meno in Italia.
Da Wikipedia:
Till Eulenspiegel è un personaggio del folclore del nord della Germania e dei Paesi Bassi.
Secondo la tradizione sarebbe nato a Kneitlingen, nel ducato di Brunswick, intorno al 1300 e sarebbe morto nel 1350 a Mölln.
[...]Il personaggio di Till Eulenspiegel ha ispirato diverse opere.
Un libro che narrava le sue avventure fu pubblicato nel 1510. L'opera è anonima, ma si ritiene sia di Hermann Bote.
Questa prima (!) edizione in italiano riprende questa prima versione del 1510, però integrata da alcune versioni successive.
Un'ultima nota: anche se si tratta di un'economica brossura, la fattura del volume è veramente buona.
Il personaggio
Sorge spontanea la tentazione di fare un parallelismo con il Bertoldo di
Giulio Cesare Croce del quale ho parlato
questa pagina:
entrambi i libri sono stati scritti nel XVI secolo, (anche se quello del Croce è stato pubblicato successivamente, nel 1620),
ed entrambi hanno per protagonista un popolano di umile estrazione ma grande intelligenza e arguzia.
Entrambi i personaggi sfruttano la propria intelligenza contro i potenti, o comunque contro le classi sociali superiori,
e forse proprio per questo sono ambientati nel passato ma ammiccano al presente, come i "Promessi sposi" manzoniani, per non puntare il dito troppo direttamente.
Per la precisione entrambi sono ambientati nel medioevo: Bertoldo nel VI secolo, ai tempi di re Alboino, e Till Eulenspiegel nella prima metà del '300, come riportato sopra.
Entrambi sono catartici per le classi più basse rappresentando una sorta di riscatto dell'intelligenza contro il potere e la ricchezza.
Detto questo le similitudini si fermano bruscamente.
Bertoldo è un individualista che però alla fine è integrato alla corte di re Alboino.
Viceversa Eulenspiegel è un vero e proprio anarchico, insofferente del potere, sprezzante anche verso gli arroganti della sua classe sociale.
Quelli di Bertoldo sono scherzi relativamente fini e innocenti, mentre quelli di Eulenspiegel sono scherzi in genere pesantissimi, quando non sono vere e proprie truffe o furti.
Nei novantotto racconti del libro si percepisce una certa coprofilia: la merda è usata come il prezzemolo, la troviamo un po' ovunque.
Ma feci a parte c'è sempre della durezza in tutti gli scherzi che spesso rappresentano un danno economico per i malcapitati di turno,
che in buona parte dei casi sono artigiani o borghesi a cui Eulenspiegel va a chiedere lavoro.
Però in generale non risparmia nessuno: anche in punto di morte si prende gioco della propria madre e del confessore che speravano di spillargli dei quattrini.
Il linguaggio
Se escludiamo le vere proprie truffe, nonché i furti, che pure fanno parte del personaggio, in quel che resta troviamo la parte più interessante e, oserei dire, filosofica di questi racconti. Till Eulenspiegel non imbroglia nessuno: semplicemente prende alla lettera quel che gli si dice, ignorando o fingendo di ignorare tutte quelle sovrastrutture composte da figure retoriche o da sottintesi comunemente accettati.
I giochi anfibologici e paranomasici, con i loro effetti deformanti, demistificanti e stranianti dell'uso consueto del linguaggio quotidiano, stanno a testimoniare il rifiuto da parte di Eulenspiegel del linguaggio normale degli altri: ma la non accettazione del linguaggio usuale degli altri è indice anche e soprattutto del rifiuto del mondo degli altri. E alcune storie, caratterizzate da una particolare gesticolazione di tipo anale, sembrano proprio indicare questa direzione di disprezzo assoluto per gli altri e di totale rifiuto degli altri.
In questo passaggio dell'introduzione Luigi Tacconelli facendo un certo uso di parole ricercate e desuete rischia di cadere nella stessa casistica che denuncia.
Sperabilmente però il suo non è un tentativo di esclusione, ma un invito all'evoluzione: appropriatevi di certi termini che non rientrano nel linguaggio comune,
e date loro una nuova giovinezza.
E' quindi doveroso raccogliere l'invito per "anfibologici e paranomasici", però la "gesticolazione di tipo anale" mi sa tanto di
poesia demenziale alla
Robert Freak Antoni,
ed Elio e le Storie Tese potrebbero farci sopra una canzone.
Personalmente più degli aspetti psicologici, sociali e politici, trovo in questo meccanismo un aspetto filosofico.
Secondo Wittgenstein "la filosofia è una battaglia contro l'incantamento del nostro intelletto, per mezzo del nostro linguaggio",
concetto poi ripreso nel Tractatus: "tutta la filosofia è «critica del linguaggio»".
Non posso competere col buon Ludwig, e per questo abuso delle sue citazioni. Sempre dal Tractatus:
Il linguaggio traveste il pensiero. Lo traveste in modo tale che dalla forma esteriore dell'abito non si può inferire la forma del pensiero rivestito; perché la forma esteriore dell'abito è formata a ben altri fini che al fine di far riconoscere la forma del corpo. Le tacite intese per la comprensione del linguaggio comune sono enormemente complicate.
Insomma il linguaggio è quella cosa che ci limita nella conoscenza.
Le "tacite intese per la comprensione del linguaggio comune" che Eulenspiegel finge di non capire, o che realmente non capisce perché sono complicate,
sono lo specchio che mostra il limite che le persone rifiutano di accettare: "i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo".
Lo specchio e la civetta sono i due simboli di Eulenspiegel, questo oltre che l'iconografia ce lo dice il suo nome tradotto:
Eulen è il plurale di gufo e Spiegel è lo specchio.
Quindi se da una parte lo specchio è quello che mostra i propri propri limiti, dall'altra la
civetta
è il simbolo, secondo Hegel, della preveggenza filosofica che è in realtà una post-veggenza:
"in quanto pensiero del mondo essa appare soltanto dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s'è bell'e assestata",
così come la civetta animale appare solo dal crepuscolo in poi.
Così come i turlupinati da Eulenspiegel si accorgono troppo tardi dell'inganno subito.
L'informatica
Mi consento di fare alcune considerazioni in parte tecniche, e in parte personali, un piccolo sfogo insomma.
C'è una vecchia barzelletta in inglese che si può trovare in rete. La riporto sia in originale che con la traduzione:
A wife asks her programmer husband to go to the store:
"Can you go down to the store, and get a gallon of milk, and if they have eggs, get 6."
Later on he returns home and she looks at his purchases and says "Why the fuck do you have 6 gallons of milk?"
He responded "They had eggs."
Una moglie chiede al marito programmatore di andare al supermercato:
"Puoi andare al supermercato a prendere un gallone di latte e, se hanno le uova, prendine 6."
Più tardi, lui torna a casa e lei guarda la sua spesa e chiede "Perché diavolo hai 6 galloni di latte?"
Lui risponde "Avevano le uova."
Chiaramente l'umorismo di questa situazione inviterebbe a ridere dell'ottusità del programmatore.
Personalmente invece mi fa sorridere perché mi ricorda la limitatezza non solo del linguaggio, ma del pensiero comune,
che è poi quello che mi ritrovo ad affrontare come programmatore ogni volta che devo fare un'analisi con chi mi sta richiedendo del codice,
un programma per fare un lavoro.
Ma ribaltiamo per un attimo la conclusione.
Bastava poco alla moglie per essere chiara: "se ce le hanno prendi anche 6 uova", laddove la condizione "se ce le hanno" è addirittura ridondante
poiché se non ci sono è difficile prenderle.
Cosa c'entra questa barzelletta è presto detto.
Se al posto del "marito programmatore" mettiamo Till Eulenspiegel possiamo aggiungerla come capitolo del libro: è perfetta.
L'informatica, e più specificatamente i software che comunicano direttamente con gli utenti, sono potenti e limitati:
da una parte veicolano le informazioni in modo utile e proteggono da molti errori (quando possibile vengono sempre chiesti controlli sui singoli campi),
d'altra parte non ammettono fantasie, non danno nulla per scontato.
Come tutti mi sto facendo una domanda da un po' di tempo: l'intelligenza artificiale sostituirà la mia professione nel mondo del lavoro?
Senza ipocriti ottimismi dove chi rifiuta la novità è bollato come ottuso,
e senza devastanti pessimismi che ipotizzano la maggioranza della popolazione disoccupata, senza tetto e affamata,
cerco di immaginarmi come potrà essere il prossimo futuro, che in realtà potrebbe essere già il presente se non ci fossero delle inerzie di mezzo.
Ovviamente la risposta sicura non ce l'ho, però nel tempo ho osservato come in generale le persone scatenino la propria creatività negli output,
nella presentazione dei risultati o anche solo nelle videate di inserimento, mentre mantengono una certa refrattarietà alle logiche di inserimento
e gestione dei dati.
In termini brutali: succhiano la polpa, ma avanzano volentieri l'osso.
Il successo dei fogli di calcolo, con la possibilità di gestire colori, font, dimensioni, di aggiungere immagini, segni e quant'altro
ha fatto sentire tutti informatici.
Però poi la richiesta finale è sempre quella: dovresti caricarmi i dati in modo che io possa presentarli come dico io.
Interagire con un'intelligenza artificiale per comporre un format di inserimento spiegando il tipo di controlli da fare campo per campo potrebbe essere noioso: troppa logica e poca creatività.
Quindi forse per questo ed altri analoghi motivi noi programmatori non resteremo disoccupati.
L'esempio
Da "La XX storia", pag. 86:
Eulenspiegel disse: "Maestro mi dovreste dare un lume perché io possa vederci nel setacciare".
Il fornaio gli disse: "Io non ti do nessun lume. Per quest'ora non ho mai dato un lume ai miei garzoni.
Essi dovevano setacciare al chiaro di luna. Altrettanto devi fare anche tu".
Eulenspiegel disse: "Se essi hanno setacciato in questo modo, anch'io voglio fare allo stesso modo".
Il maestro andò a coricarsi e andò a dormire un paio d'ore.
Nel frattempo Eulenspiegel prese il setaccio, lo stese fuori dalla finestra e setacciò la farina nel cortile,
là dove la luna riluceva, spostandosi secondo il chiarore.
Quando dunque il fornaio si levò e voleva andare a cuocere, Eulenspiegel stava ancora lì a setacciare.
Allora il fornaio vide che Eulenspiegel setacciava la farina nel cortile, che era diventato tutto bianco di farina.
Allora disse il maestro: "Che diavolo stai facendo qui? Credi che la farina non mi sia costata molto, se la setacci nell'immondizia?".
Eulenspiegel disse: "Non mi comandaste di setacciare senza lume al chiarore della luna? Così ho fatto".
[...]
Il maestro s'adirò e disse: "Tu andrai a prendere il diavolo! Vai alla forca e riportami il ladro". "Sì", diss'egli e si recò al patibolo.
Lì per terra giaceva il cadavere di un ladro, caduto giù dalla forca.
Se lo caricò a spalle lo portò a casa e disse: "A quale scopo lo volete avere? Io non saprei come utilizzarlo nel modo migliore".
Com'è intuitivo, anche senza leggere la nota a piè di pagina, l'espressione "Tu andrai a prendere il diavolo! Vai alla forca e riportami il ladro" era un modo un po' più articolato per mandare al diavolo qualcuno.
Autore: A cura di Luigi Tacconelli
Titolo: Till Eulenspiegel
Editore: Salerno Editrice
Copertina: Brossura
Pagine: 310
Anno di pubblicazione: Novembre 1974
Dimensioni: 21 × 13,5 cm
EAN: 88-85026-29-x
Prezzo: 8.500 Lire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| * HOME * | * LIBRI * |